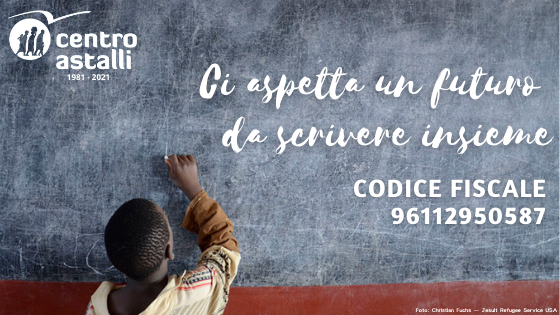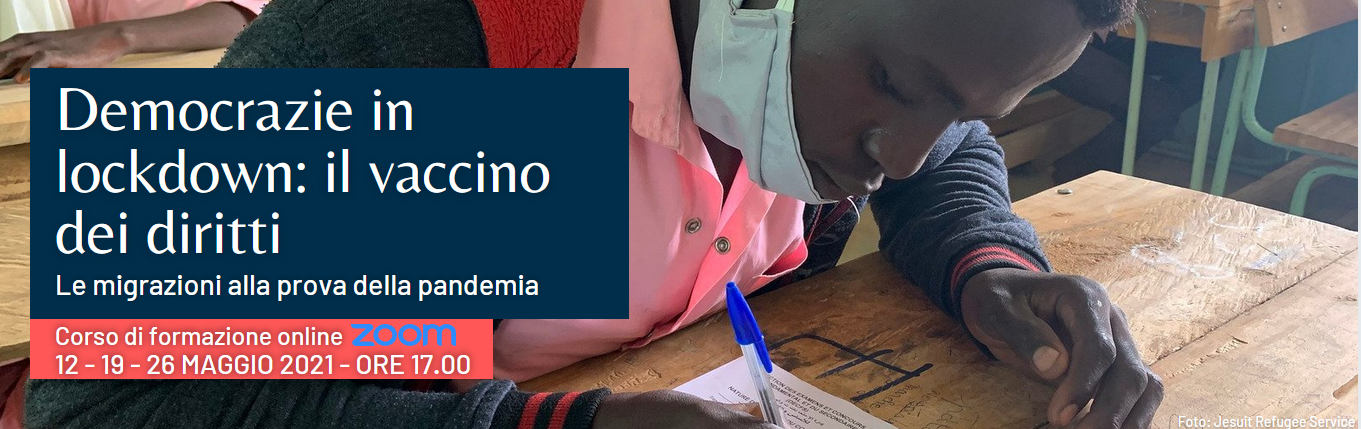2020: la cura per un mondo malato è l’amicizia sociale
Peggio di questa crisi c’è il dramma di sprecarla. Nel bel mezzo della pandemia con una campagna vaccinale che stenta a decollare, ci fa da monito questa indicazione di papa Francesco. Il 2020 sarà un anno che ricorderemo per l’inizio di un’emergenza sanitaria globale. Il 2021 potrebbe essere però l’anno che ci offre l’occasione per ripartire con uno stile di vita diverso, più attento alla cura gli uni degli altri e più rispettoso della nostra casa comune.
Nel mondo continua a essere molto alto e sempre in crescita il numero di persone che fuggono dalla propria casa a causa di guerre, violenze, cambiamenti climatici: circa 80 milioni (UNHCR, mid-year trends 2020). Tra questi oltre 45 milioni sono gli sfollati interni, ai quali papa Francesco ha indirizzato il messaggio della 106ª Giornata del migrante e rifugiato: poco conosciuti, poco tutelati perché a proteggerli dovrebbero essere i governi dei rispettivi Paesi di appartenenza.
Nei primi mesi del 2020, l’UNHCR ha registrato una diminuzione delle richieste d’asilo (-33%) e dei nuovi rifugiati a causa della difficoltà negli spostamenti e dell’accesso in Paesi sicuri. Durante il primo picco della pandemia, ad aprile 2020, 168 Paesi hanno chiuso le loro frontiere e circa 90 di questi hanno interdetto l’accesso anche alle persone in cerca di protezione internazionale. Ma le situazioni di crisi non si sono certo arrestate. Il 67% di tutti i rifugiati scappa da 5 Paesi, luoghi di instabilità da anni: Siria, Venezuela, Afghanistan, Sud Sudan e Myanmar. Il triste primato è detenuto dall’amata e martoriata Siria, come sempre la definisce papa Francesco. Dieci anni di conflitto che hanno determinato oltre mezzo milione di morti, 6,6 milioni di rifugiati e quasi 7 milioni di sfollati.
Sul versante europeo il 2020 è stato l’anno della presentazione del Nuovo patto per le migrazioni e l’asilo (settembre 2020). Le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: «Adotteremo un approccio umano e umanitario. Salvare vite in mare non è un’opzione. E quei Paesi che assolvono i loro doveri giuridici e morali o sono più esposti di altri devono poter contare sulla solidarietà di tutta l’Unione europea» (Discorso sullo stato dell’Unione 2020) avevano fatto ben sperare. Eppure sembra che a guidare il documento sia ancora una logica difensiva che punta principalmente al potenziamento dei controlli alle frontiere, ai rimpatri e a una solidarietà non di sostanza. Infatti, anche nell’anno della pandemia, nonostante il virus abbia dominato la scena, sono continuate meno evidenti le politiche di esternalizzazione dei confini. La Libia continua a essere Paese non sicuro in cui molti migranti sono detenuti illegalmente e sono vittime di violenze e gravi violazioni dei diritti umani. Sono 1.401 secondo l’UNHCR le vittime accertate dei naufragi nel Mediterraneo, che si conferma una delle rotte più pericolose al mondo, in cui il traffico di esseri umani rimane l’unico modo per giungere in Europa in assenza di vie legali di ingresso.
La fine del 2020 ha riportato al centro del dibattito pubblico la rotta balcanica che, costringe migliaia di migranti a vivere in campi di fortuna o all’addiaccio nel tentativo di superare i confini tra Bosnia, Croazia, Slovenia e Italia, a tentare e ritentare il cosiddetto the game: l’attraversamento delle frontiere con il rischio molto alto di essere rimandati indietro e venir colpiti e percossi brutalmente dalle forze di polizia.
In Italia la pandemia ha colto di sorpresa anche i rifugiati e i migranti dopo anni di politiche che hanno reso la loro vita sempre più precaria: persone ai margini, spesso sfruttate e intrappolate nelle maglie di lavori irregolari, la cui salute, nella povertà, si è fatta fragile, spesso costretti in alloggi fatiscenti, promiscui o irregolari. Tutto questo, acuito negli ultimi due anni dai Decreti sicurezza, si è trasformato in una trappola di emarginazione ed esclusione. La “stessa barca” su cui tutti ci siamo ritrovati ad affrontare la pandemia, che per un momento ci ha fatto sembrare tutti uguali, ha reso drammaticamente evidenti le disuguaglianze che abbiamo alimentato in anni di politiche che hanno smantellato il welfare. I rifugiati e i migranti insieme a tante categorie fragili stanno subendo le conseguenze più dure di questo tempo faticoso che a partire dalla crisi sanitaria ha innescato una profonda crisi economica e sociale. Si devono tuttavia registrare nel corso del 2020 timidi tentativi di invertire la rotta di un Paese che ha fatto dei migranti spesso il capro espiatorio: il decreto legge del maggio 2020 che conteneva le indicazioni per l’emersione del lavoro irregolare e l’abolizione dei decreti sicurezza va in questa direzione. Pur nella loro relativa efficacia (all’inizio del 2021 sono poche le domande di regolarizzazione lavorate) e parzialità, queste norme – ottenute fosse anche per semplici interessi politici o di convenienza legata alle circostanze – hanno dimostrato tuttavia che è possibile percorrere una strada diversa quando c’è una volontà politica. Quindi il 2021 potrebbe essere l’anno che, nella prospettiva della ricostruzione che guarda al post pandemia, vada nella direzione di un’amicizia sociale perseguita attraverso la ricostruzione di uno stato sociale che non discrimini ma includa.
Infine un ringraziamento a volontari, operatori e sostenitori in questo 2021 in cui si celebrano i quarant’anni del Centro Astalli. L’anno che ci lasciamo alle spalle è stato certo terribile per la globalità della crisi, ma non possiamo dimenticare che le persone che accompagniamo hanno esistenze spesso attraversate da crisi drammatiche. Possa l’esperienza di una comune vulnerabilità essere stimolo per una condivisione che apra un orizzonte fraterno.
P. Camillo Ripamonti sj
Presidente Centro Astalli