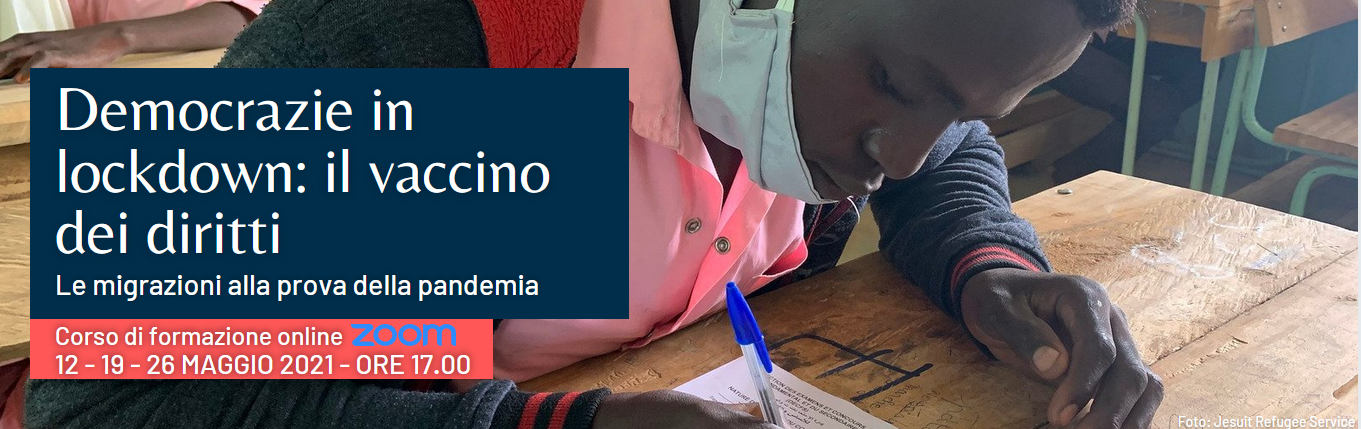Ritratti di migranti
L’arte ha la capacita di raccontare, attraverso prospettive diverse, l’esodo interiore ed esteriore degli essere umani, la fuga di milioni di persone, uomini, donne, bambini, anziani in cerca di futuro e di pace.
La migrazione era già una realtà dipinta da numerosi artisti italiani di fine Ottocento. Negli ultimi decenni del XIX secolo, il Verismo, infatti, documentò le disuguaglianze e le miserie dell’Italia post unitaria attraverso vere e proprie opere di denuncia sociale. È in questo contesto che la pittura italiana venne a contatto con l’emigrazione.
Il pittore Angiolo Tommasi nel dipinto Gli emigranti ha rappresentato le paure e le speranze di tanti nostri connazionali. Tommasi dipinge un porto e l’attesa di una folla in partenza per l’oltreoceano. Sul fondo le navi: un futuro sospeso, irraggiungibile. In primo piano, contadini, commercianti, artigiani. Volti scavati dalla fame su una banchina gremita. Alcuni uomini hanno già voltato le spalle al passato, altri non riescono ancora a guardare oltre il mare, al futuro. L’autore traduce i sentimenti di questa folla in quattro icone tipologiche: una donna pensierosa sorregge il capo con la sua mano, un’altra allatta il proprio bambino, un’altra ancora si accarezza il ventre, un’anziana signora fissa la corona del rosario che scivola fra le sue dita. Nei volti di queste donne sono presenti i dubbi e le domande di tutti. Precarietà, speranza, fame, passato e futuro, tutto è ritratto in questa attesa. La moltitudine di barche a vela e la folla di emigranti bene esprimono, nel dipinto, la vastità del fenomeno migratorio dall’Italia del secondo Ottocento: intere famiglie o gruppi di uomini, umile gente macerata da una vita di stenti, con la malinconia sul viso e la speranza nel cuore, si apprestano al grande viaggio che durava almeno 15 giorni in condizioni molto disagiate, se non inumane.
Accanto a queste grandi narrazioni, c’è chi ha voluto ritrarre l’ultimo saluto sulla banchina, il bacio dei figli ad un padre in partenza, il distacco e la solitudine che irrompe al momento dL’artista in Emigranti riproduce lo stesso soggetto di Tommasi, la partenza, in un momento identico, l’attesa dell’imbarco, ma rappresenta tutto ciò in modo diverso. La partenza è vissuta come distacco, solitudine, dolore, una vicenda personale e familiare. La famiglia è al centro del quadro, l’uomo ha in braccio una bambina e la sta baciando, un’altra è aggrappata alla giacca; le due donne di spalle con il viso nascosto, il capo chino sembrano osservare e con il loro dolore tenuto a freno davanti alle bambine.ell’addio, tra questi Raffaello Gambogi.
L’artista in Emigranti riproduce lo stesso soggetto di Tommasi, la partenza, in un momento identico, l’attesa dell’imbarco, ma rappresenta tutto ciò in modo diverso. La partenza è vissuta come distacco, solitudine, dolore, una vicenda personale e familiare. La famiglia è al centro del quadro, l’uomo ha in braccio una bambina e la sta baciando, un’altra è aggrappata alla giacca; le due donne di spalle con il viso nascosto, il capo chino sembrano osservare e con il loro dolore tenuto a freno davanti alle bambine.
Una pittura quella del XIX secolo capace di dare voce alle miserie e alle contraddizioni del tempo. Un’ arte che assume la responsabilità della denuncia e che stimola messaggi di solidarietà attraverso forme artistiche.
Molti sono i modi in cui anche l’arte del nostro tempo ha raccolto la sfida di raccontare il mondo delle migrazioni forzate. C’è chi ha scelto la provocazione, chi l’immediatezza della cronaca, c’è chi ha fatto della propria fuga il soggetto di un’esperienza artistica.
La serie di sculture di Bruno Catalano (colate in bronzo e modellate con l’argilla) che prende il nome de Les Voyageurs collocate sul perimetro del porto di Marsiglia, lasciano completamente sbigottito l’osservatore, che pur percependo il vuoto realizza la figura, percependo il significante tocca il significato.
Dal porto arriva chiaro il messaggio, incentrato sul viaggio, come dice lo stesso titolo della serie. Un viaggio di emigranti che dilania, un percorso non cercato, ma dovuto a causa delle circostanze della vita, il viaggio di chi lascia nella propria terra da cui è partito un pezzo di sé. Gli occhi non sono felici, lo sguardo è rivolto verso un orizzonte incerto e incompleto, la mano stringe la valigia, quasi rappresentasse tutta la vita, tutto ciò che si possiede. Il vedere attraverso le figure lacerate è uno scorgere insieme a loro orizzonti, vicoli ciechi, piazze e strade percorribili. I soggetti sono uomini e donne dal passo stanco, che portano con sé un bagaglio metaforicamente pesante, che camminano per la città o aspettano seduti su di una panchina l’arrivo di un mezzo. Le opere, così immerse nello spazio pubblico, dialogano con il tessuto urbano e con il paesaggio come persone vere.
La riflessione e la sua messa in opera deriva con ogni probabilità dalla vita stessa di Catalano, un marinaio francese che ha iniziato a lavorare il bronzo all’età di trenta anni. Nato nel 1960 nel sud della Francia, Catalano ha vissuto fino a 12 anni in Marocco e ha poi fatto il marinaio. Dice l‘artista: “Proveniente dal Marocco anche io ho viaggiato con valigie piene di ricordi che rappresento così spesso nei miei lavori. Non contengono solo immagini ma anche vissuto, i miei desideri: le mie origini in movimento”. Da qui la sua evidente attenzione per il tema del viaggio, dei viaggiatori, del significato simbolico ed intrinseco del viaggio, inteso come arricchimento e come perdita. Nessun arrivo, nessuna partenza può dirsi realmente completa. Il viaggio dei migranti è sempre doloroso e Catalano lo ‘fotografa’ nel suo svolgersi. La decisa mancanza di volume invita lo spettatore alternativamente a perdersi nello sfondo o a completare il disegno. Ma il vuoto è proprio lì, all’altezza degli organi vitali e bisogna imparare a conviverci.
Sono molti gli artisti che a causa di guerre e persecuzioni hanno dovuto lasciare il proprio paese per cercare protezione in un paese straniero e che hanno raccontato il mondo dei migranti a partire dalla propria esperienza personale, tra questi Adrian Paci e Rabee Kiwan. Mondi lontani, biografie diverse, l’uno albanese l’altro siriano.
Nelle opere di Adrian Paci esperienza biografica e ricerca artistica s’influenzano vicendevolmente e le sue produzioni spaziano dalla pittura al video, dalla fotografia alla scultura. Cambiano le forme, i supporti, le espressioni, ma le migrazioni sono il tratto caratteristico delle sue narrazioni.
Attraverso opere di video-arte Paci comincia a catturare il transito. Come davanti a un video a rallentatore, congela movimenti, espressioni, isolando gesti e personaggi: “Ho iniziato a usare il video per raccontare le mie esperienze. I pennelli non mi bastavano, mi serviva qualcos’altro. Ma l’impronta della pittura è rimasta, anche quando scattavo foto o giravo con la camera”.
Adrian Paci / Centro di Permanenza Temporanea from cfmt on Vimeo.
Nel video Centro di Permanenza Temporanea, un gruppo di persone attraversa lentamente la pista d’atterraggio di un aeroporto per salire sulla scaletta che conduce all’ingresso dell’aereo. La telecamera inquadra in successione i passi e i volti di questa processione fatta di uomini e donne. Indifferenza, attesa, preoccupazione sono le emozioni che li accompagnano. Dietro di loro il nulla. Che cosa guardano? Dove sono diretti? L’opera di Paci, lascia spazio a più interpretazioni, e racconta i sentimenti e il destino di molti migranti per i quali un approdo non c’è.
Molto simile all’esperienza del viaggio bloccato, dell’itinerario spezzato è il lavoro della fotografa e artista iraniana Gohar Dashti, che ha vissuto ancora bambina l’esperienza della guerra durante il conflitto Iran-Iraq, 1980-1988. In Iran, Untitled, attraverso le sue foto fornisce un delicato sguardo sulla vita che scorre alla periferia di Mashhad, a mille chilometri da Teheran. La vita nelle sue opere si trasforma in arte e racconta la vulnerabilità degli sfollati a causa delle guerre, di coloro che sono in transito in un non luogo, come il deserto.
L’artista siriano Rabee Kiwan di fronte all’esodo dei suoi connazionali (lui stesso si è rifugiato in Libano) riflette sull’identità personale e su quella di un popolo, come il suo, che subisce la guerra. In Passport photo l’artista dipinge una serie di fototessere e di timbri ricostruendo così il particolare rapporto che ogni rifugiato ha con i propri documenti.


Ritratti anonimi, sfigurati, simili a passaporti sgualciti. Le fototessere sui documenti, sui passaporti rivelano un duplice messaggio: sono quello che ci identifica nei confronti degli altri e senza i quali non esistiamo, lo scriveva Joseph Roth negli anni trenta, e allo stesso tempo sono ciò che testimonia un’appartenenza collettiva ad un popolo, ad una nazione. Senza non si è nessuno e non si appartiene a nessun Paese, nessuna terra.
Ai Weiwei, uno degli artisti più globali e mediatici del terzo millennio, dal 2015 ha deciso di mettere la sua arte a servizio dei rifugiati, affrontando in vario modo il difficile tema del dramma dei migranti forzati. Ha avuto rapporti controversi con il suo Paese, la Cina, dove è stato anche in prigione per 81 giorni, nonostante ormai gli sia permesso girare in ogni angolo del mondo è costantemente tenuto sotto osservazione. Le sue opere hanno un chiaro carattere di denuncia di quanto milioni di persone stanno vivendo nel mondo.
A Praga nel 2016, in occasione di una sua esposizione, ha deciso di coprire alcune sue statue con i teli termici utilizzati dai migranti per attirare l’attenzione sulla loro condizione. A tal proposito dice: “Ho voluto metterle sulle mie statue per protestare contro il fatto che l’umanità sta scomparendo dai nostri cuori”.
Ai Weiwei ama stupire, interrogare, lo ha fatto anche alla Konzerthaus di Berlino dove 14 mila giubbotti di salvataggio ricoprivano le imponenti colonne e campeggiava un grande manifesto con l’hashtag #SafePassage. Un appello per l’apertura di corridoi umanitari che permettano di evitare le stragi nel Mediterraneo. Una sorta di “memoriale” temporaneo dedicato ai migranti e ai rifugiati.
A Firenze ha proposto un allestimento clamoroso di Palazzo Strozzi, uno dei più bei palazzi del Rinascimento, appendendo sulla facciata 22 canotti di salvataggio, a copertura delle finestre del primo piano. L’opera si intitola Reframe, cioè “nuova cornice”. “Non è una provocazione ma un invito ad un altro modo di sentire l’umanità” ha detto l’artista.
Recentemente è stata inaugurata a Palermo Odyssey, un’installazione che nasce da un progetto di ricerca sui rifugiati e sui campi profughi nel mondo, che mira all’analisi della cornice storica, politica e sociale in cui la “crisi dei rifugiati” si sviluppa.
Si tratta di un “floorpaper” che copre i circa 1000 mq dello spazio espositivo composto da un intreccio di immagini organizzato in una lunga e ininterrotta serie di illustrazioni stilizzate in bianco e nero che rappresentano scene di militarizzazione, migrazione, fuga e distruzione. Ha spiegato l’artista: “Io e il mio team abbiamo analizzato a fondo il tema della crisi dei rifugiati, siamo partiti dallo studio dei primi spostamenti di massa degli esseri umani, che risalgono al Vecchio Testamento. L’utilizzo della carta da parati è direttamente collegato al desiderio di trovare un linguaggio visivo che tragga ispirazione dai disegni, dalle incisioni, dalle ceramiche e ai dipinti murali delle antiche civiltà greche ed egizie. Per rendere evidente la contemporaneità della crisi, abbiamo integrato questo bagaglio iconografico con immagini tratte dai social media e da Internet, insieme ad immagini da me raccolte. Abbiamo anche esaminato la letteratura e le condizioni politiche dei vari contesti. Il disegno della carta da parati include sei temi: la guerra, le rovine della guerra, il viaggio dei rifugiati, la traversata del mare, i campi dei profughi, le manifestazioni e le proteste”.
Un altro noto artista è intervenuto con il proprio lavoro, sulla questione del trattamento riservato ai rifugiati e sulla loro gestione da parte delle istituzioni europee. Si tratta di Banksy, writer dall’identità sconosciuta, che fa dei suoi murales e della sua street art uno strumento di dissenso, protesta e denuncia sociale.

Banksy, Il figlio di un migrante siriano, Calais, 2016
Tra le sue opere più note quella che ritrae Steve Jobs, ideatore della Apple, su un muro del campo profughi di Calais, porto francese nel nord posto sul canale della Manica. In questo modo l’artista ha voluto esprimere il proprio sostegno nei confronti dei migranti. L’artista ha spiegato in un comunicato stampa: “Siamo portati a pensare che l’immigrazione dreni le risorse di un Paese e invece Steve Jobs era il figlio di un migrante siriano”. Apple è l’azienda con più profitti al mondo, paga circa sette miliardi di dollari all’anno di tasse ed esiste unicamente perché hanno accolto un giovane uomo da Homs“.
Sempre a Calais sono presenti altri tre murales in cui l’artista rappresenta il dramma dei migranti. Nel dicembre del 2015 di fronte a una spiaggia di Calais, Banksy ha realizzato uno stencil che raffigura un bambino con una valigia, che guarda in direzione dell’Inghilterra con un cannocchiale sul quale è appollaiato un avvoltoio.

Bansky, Cosette, Calais, 2016
Una delle sue opere più interessanti, posta accanto all’ambasciata francese di Londra, rappresenta una giovane donna in lacrime – probabilmente Cosette, un personaggio de I miserabili di Victor Hugo – con ai piedi una latta di gas lacrimogeno, e alle spalle la bandiera francese. Il murales è una critica aperta al trattamento riservato ai migranti nel campo profughi di Calais, nel nord della Francia sul canale della Manica, davanti alla costa inglese. La notte tra il 5 e il 6 gennaio del 2016, nel tentativo di demolire una parte della baraccopoli, soprannominata “The Jungle” (la giungla) per le condizioni in cui i migranti sono costretti a vivere, sarebbero stati usati anche gas lacrimogeni. La particolarità dell’opera sta nella sua interattività: grazie alla presenza dello stencil di un QR Code chiunque di trovi a passare in quella zona può vedere il video di quanto accaduto quella notte avvicinando il proprio smartphone.
Sempre nei pressi del porto della cittadina francese ha invece dipinto una versione moderna de La zattera della Medusa di Théodore Géricault, un dipinto del Settecento. ll quadro, a cui l’opera si ispira, rappresenta il naufragio della nave francese Méduse, avvenuto nel 1816 davanti alle coste dell’attuale Mauritania, una tragedia che ebbe grande risonanza internazionale. Nella versione di Banksy, sullo sfondo, si intravede il profilo di una moderna nave. Rispetto all’originale Banksy rovescia la scena in modo che lo spettatore possa trovarsi sulla zattera, in mezzo tra coloro che cercano soccorso. Un’opera che vuole far riflettere ancora una volta sul dramma della migrazione e sulle migliaia di morti in mare.
Un articolo “Anticorpi contro il potere” su “L’appello di Banksy in favore dei migranti e rifugiati”
muri possono diventare una tela, uno spazio aperto al mondo, persino un luogo in cui si rappresenta insieme l’ideale di un futuro comune. Alcune opere di street art ne sono un’efficace dimostrazione. Sono il frutto di incontri veri tra persone, che hanno generato consapevolezza, partecipazione, am soprattutto bellezza.
È il caso delle opere di Sibomana, nome d’arte di Antoine Durieux, artista italo-belga, cresciuto in Congo e in Ruanda.
Dopo un intenso incontro con i rifugiati eritrei, etiopi e congolesi del centro Baobab di Roma, ha scelto di raccontarne le storie nel progetto “Waves of the heroes”, lungo le rotte della migrazione in Europa (Istanbul, Lesbo, Atene, Berlino).

Sibomana – Journey to Europe, Torino. Progetto “Waves of the heros”
La mostra “I bambini del mare/children of the sea” ha invece come protagonisti i volti di dieci bambini ospitati in un centro di accoglienza della periferia di Roma. “Piano piano abbiamo preso confidenza, poi un giorno ho portato la macchina fotografica e abbiamo scattato foto per un pomeriggio intero, tutti insieme”, racconta Sibomana. “Volevo creare un qualcosa di bello e non triste, perché loro erano felici, e volevo mostrare quella positività, quella felicità nonostante tutto ciò che hanno passato”.
Le sue opere mettono insieme fotografie in bianco e nero con colori accesi, il dramma della migrazione con la forza della speranza e del futuro.
Girando per Roma è facile inbattersi in alcune sue opere, come quelle al museo dei bambini “Explora”. Tra queste il volto in bianco e nero di un bambino che scruta l’orizzonte e il mare che lo circonda, un mare mosso fatto di geometriche pennellate colorate.
’immagine è anche sulla copertina del cd Yayla – Musiche ospitali, realizzato dal Centro Astalli in collaborazione con Appaloosa Records. Sibomana ha voluto regalare al Centro Astalli anche altre sue opere: due in particolare che campaggiano sui muri del centro per l’accoglienza e l’inclusione Matteo Ricci.


Safet Zec, è un artista bosniaco scappato da Sarajevo dalla guerra in Bosnia con moglie e figli e rifugiatosi a Venezia trenta anni fa. Protagonista del movimento denominato «realismo poetico», la sua capacità di rileggere e concretizzare il fenomeno migratorio è particolarmente potente. Il ciclo pittorico “Exodus” ne è la dimostrazione: realizzato nel 2017, è composto da ampie tele create con tecnica mista, in cui fogli di giornale si impastano all’olio della tempera e al collage, racconta l’esodo dei migranti in Europa. Gli sguardi pieni di dolore negli occhi di donne, uomini e bambini, la tragedia del piccolo Aylan, il bimbo di quattro anni ritrovato senza vita sulle coste greche, un barcone colmo di persone che tendono la mano in cerca di aiuto, sono questi alcuni dei soggetti interpretati dall’artista.
«Certi pezzi di tela sono dentro di noi, ogni artista accede a ciò che si porta dentro. Non potevo che usare gli unici mezzi che conoscevo per raccontare gli orrori della guerra. In questo periodo sono nati i corpi feriti, gli abbracci», ha detto Zec.

Safet Zex – Exodus
“Nelle tele di Zec, a poppa, si osservano i bambini difesi dall’abbraccio dei genitori; le robuste mani degli uomini sorreggono, come corpi morti, la fragile esistenza dei propri figli: il proprio futuro. In primo piano sono rappresentati corpi stesi, sfiniti, avvolti in bianche vesti, come sudari. I volti visibili dei bambini sono spenti, lo sguardo perso nel vuoto. Al centro dell’opera, una forte luce bianca illumina il corpo di una bambina, con gli occhi chiusi, adagiata tra le ginocchia del padre, le cui mani dolcemente sfiorano quelle piccole di lei. A fianco si trova un’altra bambina, seduta, sul cui grembo è posto un pane, simbolo non solo dell’alimento necessario, ma anche del senso della durezza della vita, delle asperità. Per il cristiano, inoltre, esso evoca il pane spezzato di Cristo, umile tra gli umili, quel pane eucaristico che trasforma la vita e rende misericordiosi.” (La Civiltà Cattolica, «EXODUS»: L’EPOPEA DEI MIGRANTI NELLA PITTURA DI SAFET ZEC, Claudio Zonta, Quaderno 4057, pag. 88 – 92, Anno 2019, Volume III)