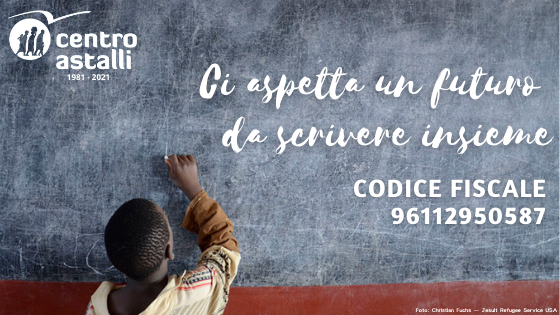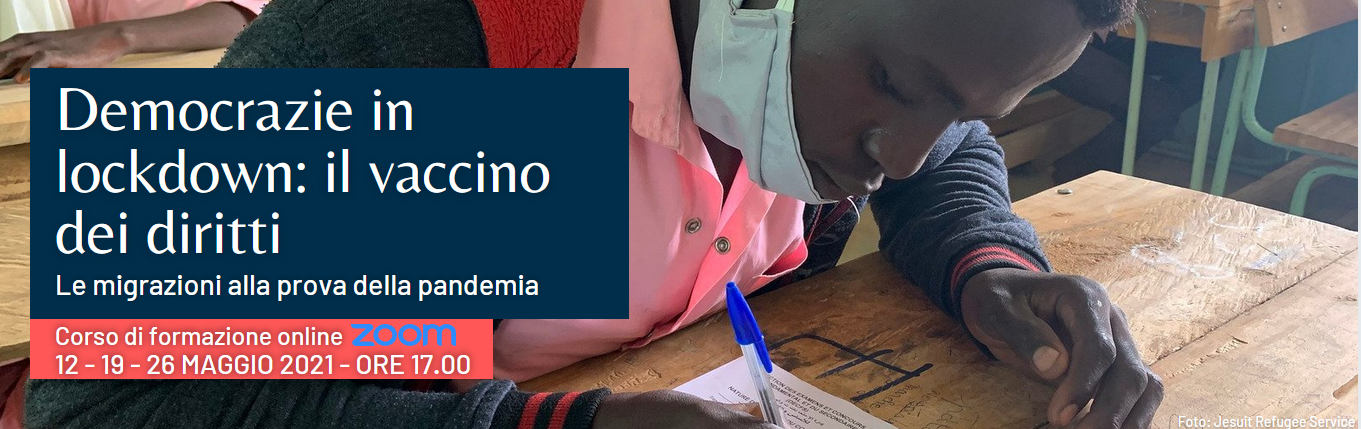Tra le chiese protestanti non può mancare la storica visita alla Tempio valdese di Piazza Cavour, costruito in epoca post risorgimentale e terminato nel 1913. Il pastore accoglie le classi e conduce gli studenti nella storia dei valdesi in Italia e nelle diverse fasi che hanno portato alla costruzione del luogo di culto.
Quella valdese è la più antica comunità cristiana non cattolica, presente in Europa da molto tempo prima della Riforma del XVI secolo. I Valdesi prendono il loro nome da un mercante di Lione, in Francia, detto Valdo, che intorno al 1170 distribuì i suoi beni ed iniziò a predicare il Vangelo assieme ad un ideale di rinnovamento della Chiesa. Subì un processo, venne scomunicato, ma egli e i suoi seguaci, i Poveri di Lione, continuarono a predicare e formarono piccole comunità, costrette a riunirsi in segreto per la repressione di cui erano oggetto.
Presenti in Italia dal XIII secolo, soprattutto in alcune vallate del Piemonte, i Valdesi aderirono alla Riforma Protestante nel 1532. Subirono sanguinose persecuzioni e sopravvissero ad un tentativo di sterminio nel 1686. I loro diritti civili e politici furono concessi solo a partire dal 1848, mentre quelli religiosi vennero poi garantiti nel 1984, con l’Intesa tra il Governo italiano e la Tavola Valdese. Il tempio valdese a Roma fu edificato nel 1910 e si ispira, nell’architettura come nella decorazione eseguita da Paolo Paschetto, alle basiliche paleocristiane, di cui conserva fondamentalmente la pianta e alcuni tratti architettonici salienti, che si colgono dietro i motivi di ascendenza liberty, tipici del gusto dell’epoca.
Sempre su cartoni del Paschetto (visibili nel Museo della Casina delle Civette a villa Torlonia) vennero realizzate dal maestro Cesare Picchiarini le vetrate, che per il valore di testimonianza ed insegnamento loro attribuito dall’autore, secondo l’uso antico, rappresentano il vero fulcro di tutta la decorazione, in cui l’atmosfera creata dai giochi floreali delle alte trifore sostiene lo svelarsi attraverso i simboli biblici del ricco contenuto della fede. Gli arredi, anch’essi curati dal Paschetto, furono realizzati da diversi artisti: il professore Augelli di Pietrasanta scolpì il fonte battesimale, L. Zalaffi di Siena forgiò i lampadari, i Corsini di Siena eseguirono la tavola ed il pulpito, i cui bassorilievi riproducono il monogramma cristiano ed i volti dei riformatori: Arnaldo da Brescia, Lutero, Calvino e Savonarola. L’organo, un sistema pneumatico tubolare, fra le ultime opere del celebre Carlo Vegezzi Bossi, è un complesso di oltre 2300 canne, in cui, grazie ad una gamma di registri sonori più tutte le combinazioni meccaniche in uso a quei tempi, convivono intonazione classica e sinfonica.
Per approfondire:
Guarda il video e scarica la nostra scheda di approfondimento!